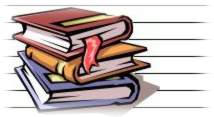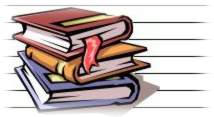RUWENZORI ’88
Il “Gruppo Amici della Montagna di Conselve”, in occasione
della ricorrenza del centenario della scoperta del RUWENZORI
ad opera dell’esploratore Henry Stanley, ha organizzato una
spedizione sul famoso massiccio africano, tentandone
la scalata. …ma, all’appuntamento mancò la “fortuna”.-
Da qualche ora eravamo in volo verso l’Africa. La nostra meta, il Ruwenzori: massiccio montuoso situato ai bordi della Great Rift Valley, nello Zaire, al confine con l’Uganda, che, con cima Margherita e cima Alberta, si eleva fino a toccare quota 5.120 m.- Eravamo sei amici in cerca d’avventura: Mario, Beniamino, Piero, Pietro, Mario e Ezio. Chi ad occhi socchiusi, chi con lo sguardo fisso all’oblò, passava in rassegna i momenti della partenza, le raccomandazioni delle mogli e degli amici, lo sguardo un po’ interrogativo dei figli. Chi invece, con la fantasia era già alle prese con corde e chiodi, o aveva calzato i ramponi per affrontare il ghiacciaio, tante volte osservato e studiato in fotografia. Alle spalle avevamo lasciato mesi e settimane di lunghe e faticose camminate in collina od in montagna. Quasi ogni sera i sentieri di Monte Ricco e Monte Venda vedevano sgambettare qualcuno del gruppo che voleva dare un po’ più di tono ai muscoli: allenamenti che si rivelarono indispensabili, anzi insufficienti. Ed ora, nel ventre di un Jumbo della Sabena, fingendo di dormire, era cominciata la nostra avventura.
Il giorno 20/06/88, all’aeroporto di Kinshasa, era ad attenderci, per unirsi a noi, l'amico Pierluigi, che già da due anni svolgeva attività di volontariato nello Zaire, per un progetto di sviluppo organizzato dalla CEE.
Lo Zaire, ex Congo Belga, (oggi Repubblica Democratica del Congo) è un paese molto vasto, grande più di 8 volte l’Italia, con una popolazione di circa 35/milioni di abitanti (oggi oltre 80 milioni ab.). Paese molto ricco di materie prime e di legname, dove però la civiltà pare essersi fermata di fronte a due grossi ostacoli: la voracità delle multinazionali e la corruzione politica. Un paese sostenuto dall’opera assidua e generosa dei missionari, unica voce, unica forza contro il diffuso analfabetismo e la miseria della gente.
A kinshasa, capitale dello Zaire, ci fermammo tre giorni, in attesa di un aereo che ci trasferisse a Beni, 1.500 km all’interno, a 60 km circa dalla nostra meta.
Dopo uno scalo a Goma per cambio di vettore, raggiungemmo Beni a bordo di un malsicuro Foker ad elica: In tutto, quattro ore di volo sopra un mare di verde. Alberi e solo alberi, di tanto in tanto si distingueva il corso di qualche fiume. Abbiamo potuto provare l’ebbrezza, meglio, la paura dei vortici e dei vuoti d'aria causati da un temporale. Poi, finalmente l’atterraggio su una pista in terra battuta e, unica strumentazione, l’esperienza del pilota.
A Beni, dopo non poche difficoltà, reperimmo una Land Rover con la quale l'indomani, attraversando la regione del Virunga, ci saremmo trasferiti a Mutsora, punto di partenza del nostro trekking.
La lunga attesa a Beni fu resa meno pesante dalla curiosità dei bambini che, a frotte, sono corsi a guardarci, ad osservarci. La loro attenzione era attratta soprattutto, dai binocoli e macchine fotografiche, così, Piero s'inventò sulla pubblica via una scuola d’ottica per una torma di ragazzi, avidi di sperimentare un moderno binocolo.
Per una pista tutta buche e sassi, dove in vere e proprie voragini giacevano camions rovesciati od impantanati e qualche autocisterna bruciata, abbiamo attraversato la foresta del Virunga. Lungo il tragitto, di tanto in tanto incontravamo branchi di babbuini, giraffe, gazzelle ed antilopi. Nell’attraversare un fiume ci imbattemmo in una famiglia di ippopotami che guazzavano pigri nell’acqua. Poco distante, appollaiata su un’acacia, un’aquila testa bianca.
Verso l’imbrunire attraversammo il villaggio di Mutwanga, una distesa senza fine di capanne sul fianco di una collina. Ancora una decina di chilometri ed eccoci a Mutsora, base e punto di partenza per salire al Ruwenzori.
La guida ci accompagnò verso un edificio in muratura, una struttura ad un piano di forma quadrata divisa in tante stanze che davano su un cortile centrale. Ci organizzammo per la notte. Finalmente potevamo riposare in una branda. Non passò tanto tempo però, che, causa dell'inconscio estro poetico e melodico di Piero e Mario, la stanza cominciò ad animarsi. Volarono delle scarpe in direzione dei due che russavano e quando, inquadrati dai fasci di luce delle torce, scorgemmo dei topi che tranquillamente correvano lungo il muro, scoppiarono fragorose risate. Un bel topo grigio invece, se ne stava tranquillo sulla testa di Piero che beatamente russava. Fortunato lui! Così, la novità dell'ambiente e la presenza dei topi ci costrinse a trascorrere la notte in un agitato dormiveglia.
L’indomani, appena giorno, bevuto un po’ di tè, ci preparammo a partire.
Mentre aspettavamo i portatori ingaggiati la sera prima con l’aiuto del comandante del vicino campo militare, cominciò a piovere, ma l’acqua non spaventò la solita torma di ragazzini, almeno li pensavamo tali, che ci guardavano, sorridevano ed assaggiavano il peso dei nostri bagagli, ammirando e forse invidiando le nostre variopinte mantelline parapioggia.
Immaginatevi la sorpresa, nell’apprendere che quei ragazzi,con un’età apparente di 12/14 anni, altri non erano che i nostri portatori. E pensare che qualcuno di noi, indispettito, aveva cercato di allontanarli anche in malo modo, buttando loro addosso qualche secchio d'acqua. Comunque, solo ad immaginare 20 kg sulle spalle di uno qualsiasi di quegli adolescenti, ci faceva sentire degli autentici negrieri. Non volendoci considerare tali, protestammo nei confronti del comandante del campo militare: forse eravamo stati gabbati.
La risposta non si fece attendere, con un largo sorriso e in un bel francese che soltanto qualcuno di noi riuscì a capire, ci disse di stare tranquilli, di non preoccuparci, ché, come s’era stabilito, il bagaglio era un affare loro. ….E noi ad obiettare ch’era soprattutto un affare nostro, ….che bagagli di quel peso, a dei bambini, mai li avremmo affidati! …E poi, non volevamo ragazzini al nostro seguito! Insomma, che proprio non eravamo venuti per fare gli aguzzini!
Il tira e molla continuò per qualche minuto ma, con nostra sorpresa, subito quei ragazzini si caricarono i pesanti zaini e, in fila indiana, sotto il nostro sguardo sbigottito e una pioggia insistente, si avviarono verso le pendici della montagna.
Stavamo attraversando rigogliose piantagioni di banane e caffè quando ci ritrovammo soli. Quel mare di verde, all'improvviso, s'era inghiottito portatori e bagagli. Erano letteralmente spariti! Ci guardammo stupiti, guardammo con occhi interrogativi la nostra guida che subito, per scacciare i nostri timori, ci fece capire che i ragazzi avevano terminato il loro lavoro e che ora toccava a gente più adulta ad accompagnarci.
Mentre nell'attesa quasi tutti approfittavano di un po’ di riposo, Piero si eclissò. Si seppe poi, che, preoccupato per la sparizione del bagaglio, se n'era andato in giro per la piantagione in cerca di qualche traccia. Capitò così nei pressi di un tucul e si mise a questionare, non si sa bene in che lingua (lui parla soltanto dialetto), con una donna che lì nei pressi della capanna pascolava alcune capre. Piero fece l'atto di portarne via una, ma la donna si mise ad urlare. Proprio in quel momento, dalla capanna usci un uomo con una faccia da eclissi lunare, sorridente e con in spalla una delle nostre sacche: era un portatore. Subito dopo, dal bananeto intorno ne spuntarono altri. Ora le sacche c'erano tutte ed eravamo un po’ più tranquilli. Ci rasserenammo del tutto osservando l'aspetto dei nuovi arrivati: si vedeva che erano adulti. Provvidenziale la sortita di Piero!?!?
Di lì a poco riprendemmo il nostro avvicinamento alla montagna. Le piantagioni ormai, facevano posto alla boscaglia. Arrivammo così alla Casa delle Guide mt. 1.700, struttura costruita dai Belgi, dove i primi esploratori si fermavano per riposare e arruolavano le guide indigene per le loro spedizioni.
Eravamo inzuppati e fradici, oltre che per la pioggia, per la condensa formatasi sotto le mantelline impermeabili. Si aspettò qualche ora, nel frattempo la pioggia cessò per far posto alla nebbia. Poi, sotto quella cappa umida, ci inoltrammo nella foresta, prendendo per un vecchio sentiero tracciato dai Belgi che, chissà quanti esploratori od alpinisti famosi, avevano calcato prima di noi.
Fango, radici, muschio, felci ed alberi, in un continuo saliscendi, reso pesante e fastidioso dal pantano e dall’umidità, immersi nel verde della foresta e nella penombra della nebbia, si camminava senza parlare. Di tanto in tanto un rivolo d’acqua, un torrente, il richiamo di un uccello, l’urlo di una scimmia. Questa atmosfera quasi irreale ci sarebbe stata compagna per sette lunghi, lunghissimi giorni, giusto il tempo della nostra marcia.
Già da qualche ora eravamo impegnati a districarci nel folto degli alberi e a inerpicarci per una vera montagna vegetale, quando, in una piccola radura apparve una costruzione in muratura e vecchie tavole, un po’ dissestata, era il rifugio Kalonge, quota 2.150m.
Era sera, non ci restava che rifocillarci e, alla luce delle torce elettriche, trovare un posto dove stendere il sacco a pelo per un riposo ristoratore. Trascorremmo una notte tranquilla e all’alba, con le ossa un po’ indolenzite ed ancora frastornati dalla fatica, raccogliemmo le nostre cose e riprendemmo il cammino. Seguimmo il sentiero su un ripido costone. Superata una breve fascia di felci giganti, entrammo in un fantastico bosco di di eriche. Sotto i nostri piedi, il suolo era coperto da un mare di muschio alto fino a mezzo metro. Sotto il muschio, più pericolose ed insidiose, le solite buche, le solite radici. L’ambiente era da favola, reso suggestivo ed irreale dalla nebbia che appena ci lasciava intravedere il paesaggio attorno.
Il sentiero teneva occupata al massimo la nostra attenzione, si inciampava sulle radici, si scivolava, si malediva, si imprecava, …si parlava poco. Di tanto in tanto, solo l’allegria del solito Piero ci distoglieva dai nostri pensieri: ci distraeva con qualche battuta di spirito e ci portava a scambiare qualche impressione di stupore e meraviglia. Dopo cinque ore di estenuante marcia, eravamo a riposare nei pressi del rifugio Mahangu a quota 3.310 m.-
Intanto, Pierluigi, causa lo scarso allenamento, cominciava a risentire della fatica, qualche altro era preoccupato per un po’ di tachicardia, resa più sensibile dalle parole della guida che, bello e sorridente, ci assicurava che il peggio doveva ancora arrivare, forse sarebbe stato proprio domani.
Miracolo! La nebbia all'improvviso ci aveva lasciato e sulla radura davanti al rifugio, riuscimmo a gustarci le ultime ore di sole. Ne approfittammo per dare un po' d'aria e sole ai nostri indumenti, ancora umidi per la pioggia di due giorni prima. Ezio e Beniamino intanto preparavano la cena.
Scambiate alcune battute, qualche parola spiritosa, stendemmo i sacchi piuma e ci mettemmo a riposare, non prima però di esserci accertati, ognuno per proprio conto, quale compagno avessimo come vicino, per non dover passare la notte in bianco, causa il gran russare che solitamente facevano Mario e Beniamino.
Al mattino la sveglia ci fu data da un tiepido sole che, dai rami degli alberi, filtrava nella radura. La colazione fu abbondante: latte, caffè, tè, marmellata e cioccolata. Poi, zaini in spalla e via. Di nuovo per fango, buche, radici, muschio ed alberi: un inferno verde. Con le ghette che ci fasciavano le caviglie ed i polpacci, con le mani infilate in robusti guanti da carpentiere, salivamo lungo il costone aggrappandoci ai rami e alle radici degli alberi, ai tronchi delle felci giganti che scoprimmo, erano muniti di piccole ma durissime e insidiose spine.
Si doveva fare attenzione, studiare ogni passo: ogni buca, ogni radice poteva essere causa di una distorsione o di qualcosa di peggio. Se fosse accaduto, il pronto soccorso più vicino sarebbe stato un campo militare, a 5 giorni di marcia; l’ospedale, forse a 200 km di pista. Ognuno di noi era conscio che doveva bastare a se stesso.
A poco a poco le radici scemarono, il muschio si fece più basso, finalmente sotto gli scarponi qualche sasso, qualche frammento di roccia nera, era finito l’incubo di fango e radici, si stava camminando su solido terreno sassoso. Su in alto, sulla sommità del colle, illuminato dal sole appariva il rifugio Kiondo. Sembrava vicino, invece lo raggiungemmo dopo più di un'ora di estenuante salita. Esausti e sfiniti ci sdraiammo per terra. Faceva freddo. Eravamo a quota 4.200 m.-
Guardando il paesaggio intorno, finalmente libero da nebbia, potemmo vedere ed ammirare i ghiacciai del Ruwenzori, ma solo per poco. Di nuovo la nebbia avvolse ogni cosa. Il freddo pungente ci fece rintanare dentro il rifugio dove già qualcuno aveva acceso il fuoco e messi ad asciugare gli scarponi, altri invece si adoperava intorno ai fornelli per una cena calda. C'era chi stava male a causa dell’effetto quota e già pensava che a quel punto la sua avventura fosse finita. Durante la notte, in preda ad incubi, lo si sentì gridare:
“Basta, non ce la faccio! Così non posso continuare! Torniamo indietro!”
L’indomani, i brutti sogni della notte erano svaniti e, sotto un bel sole, ci ritrovammo tutti sul sentiero verso il bivacco La Moraine. Davanti, grigio e cupo il Rwenzori. Più sotto, nella valle, giacevano incastonati alcuni laghetti: lago Nero, Lago Verde, Lago Bianco.
Attraversammo una zona paludosa, ancora coperta dalla brina della notte e, passo dopo passo, ci ritrovammo al bivacco: una piccolissima costruzione in legno, rovinata dall’incuria e dalle intemperie, situata sopra la morena. Poco oltre, pericolosa per il continuo precipitare di slavine, si estendeva per qualche centinaio di metri la fronte di quel ghiacciaio che, per tanti giorni, avevamo studiato ed osservato in fotografia: la nostra strada verso la cima del Ruwenzori.
Erano le 02.00 del pomeriggio, quota 4.500 m., faceva molto più freddo, l’aria era pungente ed era tornata la nebbia. Indossammo subito la giacca a vento ed in testa un caldo berretto in pile e, in fretta, piantammo due tendine, non c’era posto per una terza. Qualcuno avrebbe passato la notte tra le tavole sconnesse del bivacco. Eravamo tutti intenti alle nostre operazioni di campeggio quando, di nuovo la nebbia si diradò, sparì. Finalmente potevamo spingere lo sguardo sulla montagna, sul “re delle piogge”, …incuteva timore.
La voce baritonale di Mario ruppe l'incanto:
"Ghemo da ciapàre el giasso, là de sora!" ci diceva, indicando una lingua bianca che si estendeva sulla destra, sopra un fianco roccioso. Osservammo la parete e poi, gli occhi puntarono dritti al ghiacciaio per individuare il percorso più adatto. Qualcuno si incamminò sotto lo sperone che ci sovrastava per un sopralluogo. L’attacco, era stato deciso, l’avremmo effettuato subito l’indomani mattina alle 03.00.
Non vi nascondo la sorpresa, nel costatare che la visione diretta del luogo, era ben diversa dalle relazioni lette e dalle fotografie, vecchie di vent’anni. Il ghiacciaio si presentava completamente trasformato. Le foto lo presentavano ben innevato, molto vicino al bivacco e la sua pendenza sembrava piuttosto dolce. Stava invece davanti a noi, imponente e pericolosa, una fronte bianca, dalla quale di tanto in tanto si staccavano enormi blocchi di ghiaccio che precipitavano con fragore sopra la morena. Un problema attaccarla e raggiungere la via di salita.
Individuata la direttrice da seguire, quella lungo lo sperone roccioso già indicato da Mario, preparammo l’attrezzatura e tutto quanto sarebbe occorso per la scalata, pronti a partire alle prime ore del mattino. S’era deciso per due cordate: Mario S. con Ezio e Mario B. con Piero. Pensando al domani, ci chiudemmo nelle tendine molto presto. Faceva freddo, era gelata anche l’acqua dentro le borracce, tanto che qualcuna scoppiò. Rintanati nei sacchi piuma, riuscimmo a smaltire un po’ di fatica e un po’ di sonno.
Durante la notte, il vento fece sobbalzare le tendine, qualche lampo, qualche tuono, ma non piovve, il sonno ormai aveva fatto spazio all’eccitazione per l’imminente scalata.
Alle 03.00 eravamo già in piedi, intirizziti dal freddo. Alle 04.00, alla luce delle torce elettriche, avevamo attaccato la parete. Cominciammo a salire prima per uno spigolo roccioso, poi per sfasciumi, ancora roccia e in capo a due ore eravamo, con ramponi ai piedi, sulla lingua di ghiaccio scelta per la nostra salita. Questa, si estendeva sotto una parete di roccia nera e andava a congiungersi al corpo principale del ghiacciaio. L’arrampicata ci aveva scaldato. Ci disponemmo come stabilito per due cordate e lentamente, affondando bene ramponi e piccozza sulla neve, cominciammo a salire la dorsale. L’ambiente era dei più severi, in quel silenzio, immersi in una natura aspra e siderale, ci sentivamo piccoli: piccoli uomini, profanatori di qualcosa di sacro.
Si saliva molto lentamente causa la pendenza, 40, 50, a volte 60 gradi. Superava le nostre aspettative. L'attenzione era massima. In quella situazione, meglio evitare errori o sciocchezze di sorta. Albeggiava, e noi là, alle prese con ghiaccio, chiodi e corde, decisi a portare a termine la scalata.
Già si intravedevano le creste delle montagne vicine. Si stagliavano nitide, in un cielo blu-notte ancora pieno di stelle. Le due cime principali, Alessandra e Margherita non si vedevano, causa la nostra posizione troppo sotto alla montagna, ma, tutt’intorno e fin dove spaziava l'occhio, era uno spettacolo unico: una selva di montagne, di creste nere, né una nuvola, né il minimo velo di nebbia. Sotto di noi, appena un puntino tra le rocce, il bivacco La Moraine. Davanti un fiume di ghiaccio scendeva ripido dai fianchi della montagna. Usciva da uno stretto colatoio per allargarsi maestoso: ora liscio, ora increspato da grandi seracchi, ora solcato da profondi e pericolosi crepacci. L’altitudine, circa 4.800 m, si faceva sentire: soffrivamo tutti di un po’ di emicrania.
Superammo una ventina di metri con una pendenza di 70 od 80 gradi e, aggirando la seraccata, ci trovammo ai bordi di un profondo crepaccio. Una breve ispezione, poi con adeguate manovre di assicurazione, Mario B. scavalcò la fenditura aggrappandosi con piccozza e ramponi alla parete antistante; ripulitala dalla neve superficiale, cominciò a gradinarla a colpi di piccozza e, dopo qualche metro, piantò un robusto chiodo per assicurare la corda. Ancora qualche gradino, ancora qualche metro, ancora un chiodo e l’ostacolo era superato.
Dieci minuti dopo, erano stati recuperati anche i compagni. Non avevamo fatto più di 40 m. di salita, ma, a ben considerare, forse avevamo superato la difficoltà maggiore, infatti, poco dopo il pendio si addolciva, tornava su una pendenza di 40/50 gradi.
L’emicrania si faceva più forte, Mario B. si lamentava di continuo per il fastidio: il dolore insistente, non si attenuava. Anche gli altri soffrivano, tuttavia, si continuava ad avanzare, metro dopo metro. Riuscimmo a guadagnare un comodo posticino a cavallo di uno spuntone di roccia e ci fermammo per uno spuntino: un po’ di cioccolato ed un sorso di tè.
Stavamo in silenzio, con lo sguardo rivolto alla cima, o meglio rivolto al colatoio che, una volta superato, ci avrebbe permesso di sbucare sul plateau che congiunge punta Alessandra a Punta Margherita: ancora 150, 200 metri e saremmo stati in cima. Ci scambiammo qualche impressione e, affiorò qualche dubbio: l’emicrania non dava tregua. Ci mettemmo ancora in cammino, salivamo sul ghiaccio piantando bene i ramponi ed aiutandoci con la piccozza ma, il mal di testa si fece più lancinante. Mario B. si ferma, si toglie i guanti e prendendo un analgesico dice a Piero:
"Basta, so finìo! …Stago mae!" Si avvicinano anche gli altri, lo guardano e aspettano che si riprenda.
Intanto, a poco a poco era sparito il sole e l'ambiente si era fatto più grigio. Guardavamo ora su, ora giù. "Dai Mario, che ci siamo!" diceva Ezio e gli faceva eco l'imprevedibile Piero, alla sua prima esperienza su ghiaccio. "Forza Mario, non mollare!" La nebbia però, scesa improvvisa e fitta dalla cima, fece sì che alla mente di tutti s'affacciassero i primi dubbi: forse, …forse era meglio tornare.
In poco tempo, una cappa scura, fredda ed umida, ci avvolse tutti; avviluppò ogni cosa, fin’anche i nostri pensieri, i nostri desideri, il nostro soffrire. Ci consultammo, aspettammo circa mezz’ora, forse un’ora. Il tempo più non esisteva, c’era solo il nostro stupore, la nostra meraviglia e la speranza che la nebbia si alzasse, ma non accadde. Decidemmo allora di non rischiare oltre, anche perché eravamo alla base di un colatoio quasi verticale e difficile. L’avremmo senz’altro superato, con un po’ di pazienza e qualche chiodo ma, la nebbia, la forte emicrania e il buon senso di Mario S., ci fecero desistere. Era meglio tornare!
Così abbandonati i nostri desideri, raccolti i nostri pensieri, la nostra tristezza, ci guardammo in viso, nessuno parlava. Mario S., come per farci coraggio disse:
“ Be' tosi, no xe miga la prima volta che qualcuno se ritira a 100, 150 metri da la sima, xa altri lo ga fato”. Così, fatto appello al senso di responsabilità, col nostro più grande rammarico, cominciammo a scendere seguendo i segnali precedentemente lasciati e che a stento riuscivamo ad intravedere nella fitta nebbia.
Lentamente, con la massima attenzione arrivammo al crepaccio. Con qualche manovra lo superammo e, fissato un chiodo sul bordo, con una discesa in corda doppia guadagnammo la parte meno ripida del ghiacciaio.
Imprecando alla sorte, con in cuore il sapore amaro della sconfitta, dopo poche ore eravamo di nuovo al bivacco La Moraine dove qualcuno, preso da un fremito di stizza, si abbandonò ad un pianto dirotto. Né c’era parola che lo potesse consolare. Continuava a ripetere:
“Possibile, a 100 metri, a 100 metri! …Tosi, ghe jerimo!”
La mattina successiva, un po' frastornati dalla fatica, smontammo le tende e, dopo aver sistemata negli zaini l’attrezzatura, prendemmo la via del ritorno.
Il Ruwenzori incombeva su di noi, severo ed imponente, si udiva di tanto in tanto il boato di qualche slavina. A tratti, la nebbia e le nuvole si diradavano e ci lasciavano intravedere le candide cime, le belle regine che noi continueremo a sognare, pensando a quel giorno di luglio. Le avevamo alla nostra portata, erano là, a cento, forse, centocinquanta metri da noi ma, è il caso di dire, mancò la fortuna!
Mario Berto